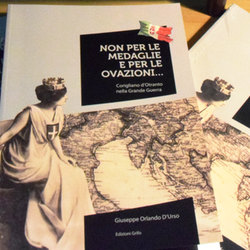Non per le medaglie e per le ovazioni
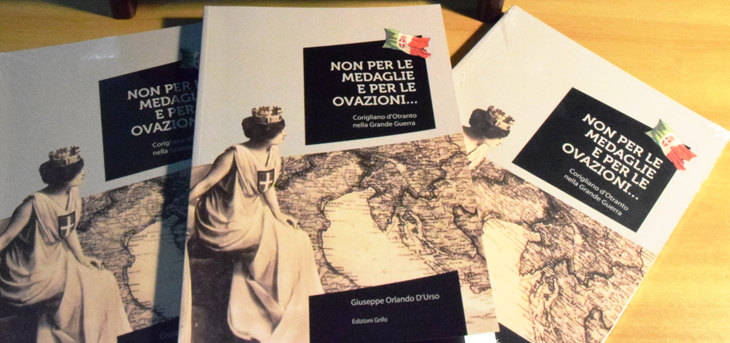
La copertina del volume di Giuseppe Orlando D'Urso sul tributo di Corigliano d'Otranto alla Grande Guerra.
Presentato al pubblico e alla stampa il volume di Giuseppe Orlando D’Urso sui venti della Grande Guerra in uno sperduto paese del Sud Italia, Corigliano d’Otranto, e la tragedia immemoriale dei suoi eroi contadini, con il moschetto in mano, mandati al massacro, chissà per cosa.
«Un giorno che la terra / sembrava tutta in pace e in armonia / scoppiò
improvviso il grido della guerra / e lugubre si sparse in ogni via.
Era l’inizio di un lungo
componimento...
Ancora vivida, a distanza di
cinquanta e più anni, l’immagine di Piazza San Nicola imbandierata, gremita di
uomini e donne – molte “nell’ovale di fazzoletti neri” – con medaglie, croci e
nastrini tricolore… e la banda, il sindaco, il maresciallo, il parroco, il
direttore didattico, gli insegnanti, le autorità… e noi, ragazzini, si cantava
l’Inno di Mameli, Il Piave mormorava, La bandiera tricolore… e la vecchia foto custodita tra centinaia
rievoca Rosanna Campanaro anche nel ruolo di “suggeritrice”, nel caso avessi
perso il filo, mentre a memoria declamavo a
tutta voce quel lunghissimo eloquio commemorativo di cui si è smemorato il
prosieguo, dispersi i fogli protocollo che lo contenevano; declamato con
enfasi, con appropriate modulazioni perché il senso di quelle parole giungesse
dovutamente non solo alle orecchie, ma soprattutto alle menti dei presenti».
Ancora una volta Giuseppe Orlando D’Urso ci sorprende piacevolmente con uno dei suoi incipit originali quanto suggestivi, più vicini al genere del romanzo che a quello del saggio storico.
Il lettore si trova immediatamente
avvolto in un periodare ampio, voluttuoso, ricco di aggettivazioni, strutturato
spesso in maniera ipotattica, ma non alieno dal ricorso alla costruzione
paratattica allorquando il discorso lo richieda. Un periodare colto,
articolato, variegato, sempre piacevole e accattivante per il lettore che ne
resta affascinato. E nonostante ciò, una scrittura mai supponente, mai oscura o
involuta, una scrittura chiara e incisiva.
A questo stile narrativo, ma nel
contempo raziocinante, argomentativo e suadente, Giuseppe Orlando D’Urso
associa, come sempre, un rigore storico veramente eccezionale.
Al di là delle sue considerazioni
e riflessioni sui fatti, sugli avvenimenti, sui personaggi, e insomma sulle
cause e sulle conseguenze delle vicende storiche di cui tratta, egli non
inventa nulla, non infioretta, non svicola, non aggiunge mai orpelli deformanti;
anzi di ogni fatto, di ogni avvenimento, di ogni accadimento – anche di quelli
di importanza minore o addirittura minima – egli dà sempre contezza al lettore,
fornendo immancabilmente la fonte d’archivio o il documento da cui con severità
inflessibile e rigore di indagine, con disciplina e scrupolosa acribia di
storico, quel fatto, quell’avvenimento, quel particolare egli ha desunto.
Ed è quanto fa anche in questo suo
ultimo stupendo libro sulla prima guerra mondiale (Non per le medaglie e per le ovazioni… Corigliano d’Otranto nella
Grande Guerra, Edizioni Grifo, 2016), denso di contenuti e incantevole nella
splendida forma data dal grande formato, dai colori, dalle foto, dalle
cartoline d’epoca, che non hanno mai una funzione meramente illustrativa, ma anzi
assurgono alla dignità di documento storico per il loro nesso specifico con le
vicende e i personaggi cui si riferiscono.
Volume di grande interesse, anche
se sono trascorsi cent’anni. D’Urso questo problema se lo pone (“A chi
interessa, a cosa serve sapere cosa è successo cento anni fa?” si domanda); ma
poi supera positivamente la domanda in termini di monito per tutti noi e per le
future generazioni. Insomma, historia
magistra vitae, per dirla con Cicerone. Anche se quella lezione non giovò
all’umanità; anzi proprio perché non le giovò.
Interessante perché è giusto non
dimenticare; perché è importante serbare memoria di quei fatti, di quei dolori,
di quelle vite spezzate, di quegli atti di eroismo, di quelle famiglie
dilacerate. Interessante perché la condanna della guerra, di tutte le guerre,
va reiterata sempre; perché la pace, come la libertà, non si conquista mai una
volta per sempre, ma deve essere tenacemente perseguita giorno dopo giorno.

Cassino, 1915.
Interessante perché Giuseppe Orlando
D’Urso ha saputo rendere ancora più intrigante, più avvincente, più
coinvolgente l’argomento, mediante due impostazioni di fondo, molto importanti,
che caratterizzano il lavoro e, come si suol dire, fanno la differenza.
Prima di tutto, l’Autore non si è limitato
alla sola ricerca negli archivi; lavoro questo, peraltro, necessario per
qualsivoglia serio discorso storico. Se D’Urso avesse circoscritto a ciò la sua
indagine, quasi certamente avremmo avuto una mera sfilza di nomi dei
coriglianesi che presero parte alla Grande Guerra: nome, cognome, data di
nascita, numero di matricola, data della morte oppure, più spesso, data in cui il
soldato veniva dichiarato disperso (il che equivaleva a dire morto), eventuali
medaglie al valore. Insomma, le scarne notizie dei fogli matricolari.
No. Egli ha esteso la ricerca sul
campo, interrogando i suoi concittadini; andando casa per casa; ricercando
lettere, missive, cartoline postali, telegrammi, comunicazioni di morte,
dichiarazioni di irreperibilità, cartoline di propaganda bellica (una
addirittura, secondo il gusto dell’epoca, in endecasillabi a rima alternata), fotografie,
medaglie, onorificenze (anche relativamente recenti, come il conferimento nel
1990 della Cittadinanza Onoraria al coriglianese Fuso Luigi, morto sul Monte
Pasubio, da parte del comune di San Biagio di Callalta); ricostruendo il
vissuto dei nostri eroi e delle loro famiglie, il lavoro, le condizioni
economiche, ecc.
Ecco perché quegli eroi coriglianesi
non sono soltanto dei nomi. Ecco perché essi balzano fuori dalle pagine del
libro come da un film che ne avesse ripreso le fattezze, i vestiti, le
abitudini, il lavoro precedente al conflitto, il contesto socio-economico e
familiare. Insomma, in una parola, il loro mondo e le loro abitudini di vita. Un
esempio per tutti: Lolli Domenico. C’è qui un vero e proprio affresco di lui e
della sua famiglia. Quattro figli maschi in quella famiglia e tutti in guerra.
Domenico, disperso (cioè mai tornato, morto); Vito Antonio, deceduto per
malattia contratta in servizio militare.
In secondo luogo – ecco l’altro
elemento d’impianto dell’opera, che la rende particolarmente pregevole – tutte quelle
vicende vengono inserite da D’Urso da una parte nella storia più grande (quella
nazionale e mondiale dell’immane tragedia che fu la Prima Guerra mondiale), dall’altra
nella storia locale, nelle condizioni economiche e sociali della Corigliano del
tempo, ricostruite in maniera dettagliata e precisa.
E tutto ciò sempre con i documenti
e le carte alla mano; compulsando gli archivi; riprendendo le delibere
consiliari dell’epoca – dalle quali traspare anche la mentalità e la cultura
del tempo, direi quasi l’aria che si respirava – analizzando le misure adottate
dall’amministrazione comunale in ordine alle opere di risanamento e
miglioramento di vie e piazze, alla creazione e ampliamento delle scuole
elementari, alle questioni inerenti alla condotta medica, alle opere pubbliche
finalizzate principalmente a dare lavoro ai tanti disoccupati, alla nascita del
nuovo borgo nel cosiddetto giardino grande, alla costruzione della nuova casa
comunale proprio durante il conflitto mondiale, alle attività industriali, all’opera
svolta dai Salesiani.
Insomma, uno spaccato della vita
coriglianese alla vigilia, durante e subito dopo la Grande Guerra.
Non manca il capitolo sugli
effetti collaterali: alcolismo, depressione, crisi isteriche, pazzia. Elementi
questi che originarono la nascita della cinica categoria dei cosiddetti “scemi
di guerra”.
Pregnanti le riflessioni intorno
alla disillusione di chi, tornato dalla guerra, non ricevette quelle
concessioni di terre che il governo aveva tante volte sbandierato, e alle
difficoltà di reinserimento dei reduci nella vita sociale.
Colpisce non poco che l’Autore
abbia scoperto proprio attraverso la ricerca finalizzata alla scrittura del
libro che suo padre, D’Urso Paolo Antonio, aveva fatto la Grande Guerra. È il
fenomeno della rimozione, sulla quale non mancano amare considerazioni.
Il titolo, tratto da un’opera di
Piero Jahier, non rappresenta una ricercatezza né tantomeno una mera citazione.
Esso, con la sua forte negazione iniziale, esprime l’essenza stessa della
partecipazione del popolo italiano alla Grande Guerra; illumina lo spirito di
quei poveri coriglianesi, di quegli eroi disconosciuti e dimenticati dalle
istituzioni nazionali che, al pari di tanti uomini del Mezzogiorno d’Italia,
andarono a più di mille chilometri di distanza a combattere una guerra di cui,
il più delle volte, ignoravano i motivi.
Perché le guerre le dichiarano i
re e i governi, ma le combatte il popolo; perché, come titolava un noto
programma televisivo, la Storia siamo noi;
perché per Giuseppe Orlando D’Urso “…nun è Storria sulu quidda crande, / ddunca
fannu le gquerre e suntu attori / reggine, papi, rre e conquistatori, / e nu
sse cunta te cinca a mmutande / fice la fama a quiddi cu sse spande”.
Quegli uomini in mutande, quasi
tutti contadini analfabeti che lasciarono la zappa per imbracciare il moschetto,
non andarono certo a combattere per le medaglie né per le ovazioni.
Franco Melissano

Una cartolina per i soldati al fronte.